
L’eredità dei territori e il futuro della politica. Intervista a Marco Almagisti
Professor Almagisti, nello studio della politica italiana adotta un approccio che mette in luce due aspetti: il peso dei territori e delle loro differenze e il ruolo del capitale sociale. Cosa si intende con capitale sociale? E che rapporto ha con una “democrazia di qualità”?
Per capitale sociale io riprendo la definizione di un politologo americano molto noto, Robert Putnam, quindi considero principalmente l’insieme dei reticoli di fiducia e delle norme di reciprocità, ossia tutto ciò che migliora l’organizzazione sociale promovendo iniziative prese di comune accordo. Questo è, a mio avviso, il capitale sociale: fiducia e potenziale di mobilitazione per l’azione collettiva. Il rapporto con la qualità della democrazia deriva dal fatto che certi processi di responsabilizzazione, quelli che, per usare un termine diffuso nel linguaggio politologico e giuridico, passano sotto il termine di accountability, sono possibili solo se c’è una forte presenza di capitale sociale. Dal mio punto di vista il capitale sociale è un prerequisito empirico fondamentale per avere delle forme di accountability funzionali e quindi un rapporto più dinamico e più maturo tra i rappresentanti ed i rappresentati.
Marco Almagisti, docente di Scienza Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, è a Firenze per presentare il suo libro “Una democrazia possibile, politica e territorio nell’Italia contemporanea”, Carocci editore. Ne hanno discusso, insieme all’autore, il Presidente della Toscana Enrico Rossi, Ilvo Diamanti, docente all’Università di Urbino, Mario Caciagli, professore emerito di scienza politica all’Università di Firenze, Stefano Casini Benvenuti, direttore dell’Irpet (che ha organizzato l’incontro) e Antonio Floridia, responsabile dell’Ufficio e dell’Osservatorio elettorale della Regione Toscana.
Qual è stato il rapporto dei partiti, nella loro veste di corpi intermedi per eccellenza, col capitale sociale?
Nel caso italiano è stato molto importante il ruolo dei partiti di massa. Il riferimento che faccio nel mio testo è appunto ai due grandi partiti di massa, democristiano e comunista, che nel secondo dopoguerra hanno non solo incapsulato il conflitto, evitando deflagrazioni potenzialmente devastanti, ma lo hanno anche “ancorato” alla democrazia. Svolgendo il ruolo di ancoraggio, hanno impedito che la società potesse distruggersi attraverso un conflitto che poteva avere esiti non democratici. Al contrario, hanno trattenuto queste forze all’interno di un sistema democratico consolidando la realtà politica e garantendo così quei decenni di democrazia di cui ha goduto fino ad ora, e speriamo possa godere ancora, il nostro Paese.
Come definire una cultura politica? E qual è l’importanza delle culture politiche nell’evoluzione dei partiti e nei meccanismi di riproduzione del consenso?
Una cultura politica è data dall’insieme di comportamenti e atteggiamenti fatti propri dalle persone, dalle prassi sociali e dai sistemi di significato, ossia dai significati condivisi che danno alle cose che fanno. Ovviamente è molto importante per i partiti, perché consente intanto al cittadino di scegliere, altrimenti i partiti si ridurrebbero a strumenti meramente intercambiabili. Invece, attraverso il riferimento delle culture politiche, mostrano dei profili che possono essere qualitativamente diversi se non alternativi. Inoltre, all’interno dei partiti, consentono di stabilire dei legami fiduciari tra le classi dirigenti, i militanti o anche i semplici simpatizzanti. La cultura politica è per l’appunto data da questa rete di rapporti e dai valori che vengono condivisi in queste interazioni.

Il suo ultimo libro verte intorno all’analisi di due contesti locali emblematici, il Veneto “bianco” e la Toscana “rossa”. Quali sono le principali differenze tra le due subculture? Incarnano anche una differente articolazione del rapporto centro-periferia?
Entrambe sono subculture politiche locali, che quindi si strutturano proprio in base a questa fondamentale linea di frattura, centro-periferia. Esse rappresentano due diverse modalità di risposta delle società locali di fronte a processi, che vengono ritenuti potenzialmente destabilizzanti, di penetrazione da parte dello Stato e anche del mercato. Le differenze riguardano le prassi consolidate in queste subculture, gli stili amministrativi e i valori di riferimento. La subcultura “rossa” della Toscana è stata più legata storicamente al municipalismo di estrazione socialista, quella veneta, “bianca”, invece più connessa alla presenza della Chiesa nella società e più orientata verso il localismo antistatalista, con alcune notevoli differenze di traiettoria storica; penso in particolare alle venature anti istituzionali più forti tipiche del Nord Est, almeno nei confronti delle istituzioni politiche centrali.
Le subculture politiche locali affondano le loro radici in un contesto storico di lunga durata. Quali sono state le tappe fondamentali nello sviluppo della Toscana “rossa”?
Certamente si tratta di una storia molto lunga e ci sono grandi maestri, come il professor Mario Caciagli, che ne ritrovano le radici già nelle esperienze della vita comunale medievale. Venendo a tempi più recenti, possiamo dire che la lunga tradizione civica, che contraddistingue la Toscana, ha trovato una manifestazione significativa già nel corso dell’Ottocento, e in particolare nella sua parte finale, attraverso le forti mobilitazioni socialiste che ne segneranno il panorama politico futuro. Questa tradizione non è andata dispersa nemmeno attraverso l’esperienza traumatica e fortemente invasiva della dittatura fascista. La dittatura ha cambiato i rapporti di forza interni, ha favorito l’emergere di un’egemonia comunista e non più socialista nel secondo dopoguerra, ma anche questa tradizione si ricollega in maniera significativa ad una storia che è più lunga rispetto alla vicenda puramente partitica del PCI.
Per quanto riguarda il caso della Toscana, quali elementi di quel modello tengono ancora oggi e quali risultano problematici? In altre parole, come sta reagendo quella cultura di fronte alla prova della crisi?
Questa è una domanda a mio avviso fondamentale, nel senso che un’idea definita riguardo a come intendere la politica e i rapporti politici permane ancora a livello di valori e anche a livello di comportamenti in questa Regione. La questione è però quella della riproducibilità del modello di sviluppo toscano, messa seriamente a rischio dalla crisi economica e anche dalla tenuta interna del modello stesso. La società cambia, ha nuove esigenze e inoltre è molto provata dalle difficoltà che sta vivendo. Siamo dentro una crisi economica invasiva da ormai otto anni, un fatto che risulta significativo soprattutto in un contesto come questo, dove il ruolo proattivo delle istituzioni locali era centrale e dove una certa idea di inclusione, se non di uguaglianza a livello sociale, era considerata l’architrave della società locale. Non è garantito che tutto ciò sia riproducibile, almeno non come lo abbiamo conosciuto in passato, e questo certamente rappresenta un enorme punto di domanda sul futuro di questa Regione, come anche di numerosi altri contesti locali del nostro Paese. Molto dipenderà da come le forze politiche attingeranno all’eredità, ancora vitale, delle culture politiche locali per affrontare questi problemi critici.
Oltre a quelle tradizionalmente prese in esame, negli ultimi anni stanno emergendo nuove linee di frattura: penso soprattutto all’opposizione tra forze “istituzionali” e movimenti anti establishment e tra europeisti/antieuropeisti. Come stanno incidendo queste spaccature, questi cleavage?
Per poterlo dire bisognerà vedere nei prossimi mesi, e nei prossimi anni, quali saranno gli attori politici che incapsuleranno queste linee di frattura. Certamente si tratterà di questioni cruciali. Siamo di fronte ad una linea di frattura che attraversa quasi tutto l’Occidente e che contrappone le forze di establishment, cioè identificabili come parte delle classi dirigenti, a quelle anti establishment. Questa frattura tocca in maniera generalizzata quasi tutti i paesi, ma accanto ad essa ci sono linee più specifiche. Per esempio un fattore che spacca la società è quello pro immigrazione o anti immigrazione e questo lo avvertiamo in quasi tutti i sistemi politici. A ciò si aggiungono reazioni diverse rispetto alla globalizzazione neoliberale, che vedono contrapposte forze più favorevoli appunto alla globalizzazione e al libero mercato e forze che invece ne sono profondamente critiche. Questo si interseca almeno in Europa con l’essere a favore o contro un certo modello di Unione Europea o perfino l’Unione Europea in toto. La situazione fino ad ora ha favorito le forze della destra radicale, che hanno riportato grandi successi e che riescono a tematizzare in maniera molto efficace l’opposizione all’immigrazione e a questo tipo di globalizzazione.
Per quanto riguarda invece le forze progressiste, si è innescato un processo di ridefinizione della sinistra a livello europeo?
Non sono solo nuove forze di destra ad essere emerse. Due riferimenti immediati sono Podemos e Syriza, che in qualche modo fanno vedere che può esistere una sinistra radicale ma per nulla estremista. Una sinistra che incarna un’idea, magari ancora non compiutamente espressa, di contestazione dell’establishment europeo per quanto riguarda la gestione della crisi e della globalizzazione. Una visione che però si declina in maniera molto diversa rispetto alla proposta della destra, per esempio è meno chiusa verso l’immigrazione, e riesce a rinominare con toni nuovi quello che è l’alfabeto socialdemocratico, attraverso una prospettiva più inclusiva della politica orientata in senso partecipativo e che non sposa una versione esclusiva e di chiusura del capitale sociale, come invece sembra fare la destra più radicale. In questi casi si vede l’importanza delle prassi sociali nella cultura politica: Syriza ha saputo generare consenso attorno alle sue proposte anche per mezzo della riscoperta del mutualismo (mense, ambulatori, scuole popolari, cooperative di lavoro e di consumo), ossia di un patrimonio immenso e nobile presente nella storia del socialismo (oltre che del popolarismo cattolico).
In questa cornice, che vede spesso la contrapposizione tra globale e locale come via per l’affermazione di numerose istanze populiste, che ruolo devono giocare le forze politiche a livello territoriale?
Intanto bisogna cominciare a ragionare sull’utilizzo del concetto di “populismo”: probabilmente lo stiamo “stiracchiando”, applicandolo a realtà fra loro molto eterogenee. Dovremmo invece cercare di analizzarlo e definirlo in modo migliore. Io sono del tutto convinto che non sia possibile pensare a nulla in politica senza considerare anche le implicazioni emotive. Non possiamo pensare di separare elaborazione politica e comunicazione, razionalità ed emozioni. Anche all’interno di quei partiti di massa di cui abbiamo parlato precedentemente si sapeva bene che esisteva una dimensione emotiva e si puntava a coinvolgerla attraverso la produzione simbolica e i rituali collettivi. Le tensioni oggi sono numerose, ci sono spinte di carattere nazionalistico che emergono fortemente proprio in questi giorni, negli Stati Uniti e in Francia, così come altre forme di riscoperta di ancoraggi territoriali subnazionali sono all’opera in Europa e in Italia, penso al Veneto, la mia Regione e al suo rapporto con la crisi. Non credo che una rinazionalizzazione completa della politica possa essere una soluzione ottimale, soprattutto per il nostro Paese che è molto diversificato. Nel Nord Est un segnale forte in questo senso è stato dato anche dal voto contro una riforma istituzionale che in Veneto era stata percepita come centralista e avvertita quindi come non in sintonia con quel localismo antistatalista che in molte forme è ancora presente nella società. Questo vuol dire che le regioni sono ancora realtà significative e attori politici importanti e che del loro ruolo si dovrà sicuramente riparlare.
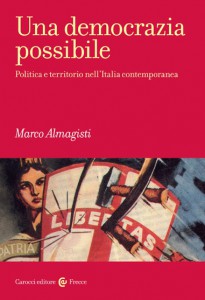
Chi sono oggi i referenti del capitale sociale? I partiti stanno perdendo il loro ruolo? Quali sono le strategie da mettere in campo?
Dovremmo pensare di considerare anche tutto quello che si muove al di fuori dei partiti, io sono sempre un sostenitore della democrazia dei partiti, però se non si guarda con attenzione al complesso fenomeno legato all’attivismo civico, che esiste al di fuori del mondo dei partiti, si percepisce soltanto una parte della realtà. Esistono milioni di cittadini che si mobilitano su questioni concrete che vanno dall’opposizione al TTIP, al consumo critico fino alla cura dell’ambiente nel loro quartiere o nella loro città. Queste forme di mobilitazione possono non passare dai partiti, ma non per questo non sono politica, anzi questi cittadini attivi sono molto spesso attori che hanno un ruolo fondamentale, perché “politicizzano le politiche pubbliche”, per utilizzare una felice espressione di Giovanni Moro. Uno dei grandi problemi dei partiti è come riuscire ad essere accoglienti, o almeno non respingenti, nei confronti di queste persone. Magari una parte di loro potrebbe scommettere sulla voglia di portare la propria esperienza anche in una realtà più istituzionalizzata e partecipare, in forme eventualmente nuove, ma comunque dentro il sistema politico formale. Fino ad ora mi pare che, nonostante siano stati fatti dei tentativi, la strada sia ancora lunga. Sperimentare come coinvolgere queste energie, che nella società esistono e sono vitali, mi pare una bellissima sfida per l’oggi e anche per il domani.
Una “democrazia possibile”, questo è il titolo del suo libro. Cosa intende?
Dico subito che io per i titoli sono negato, ne formulo sempre di troppo lunghi. Il merito è del mio editore, che lo ha deciso conoscendo bene le mie ricerche. Il titolo permette di rimarcare il fatto che la democrazia è sempre quella possibile e non coincide con i modelli ideali variamente proposti. L’Italia repubblicana ha iniziato il suo percorso politico gravata da elementi strutturali di forte difficoltà, eppure una classe dirigente di straordinaria qualità, ormai settanta anni fa, è riuscita a costruire una democrazia possibile e a garantirne la continuità, con luci e ombre, ma ci è riuscita. Si è trattato di un processo importante; gli altri paesi dell’Europa meridionale hanno dovuto attendere molto più a lungo e questo è un risultato storico eccezionale e da non dimenticare. L’Italia non è “un Paese mancato” bensì l’esempio di un processo di democratizzazione coronato da successo.



