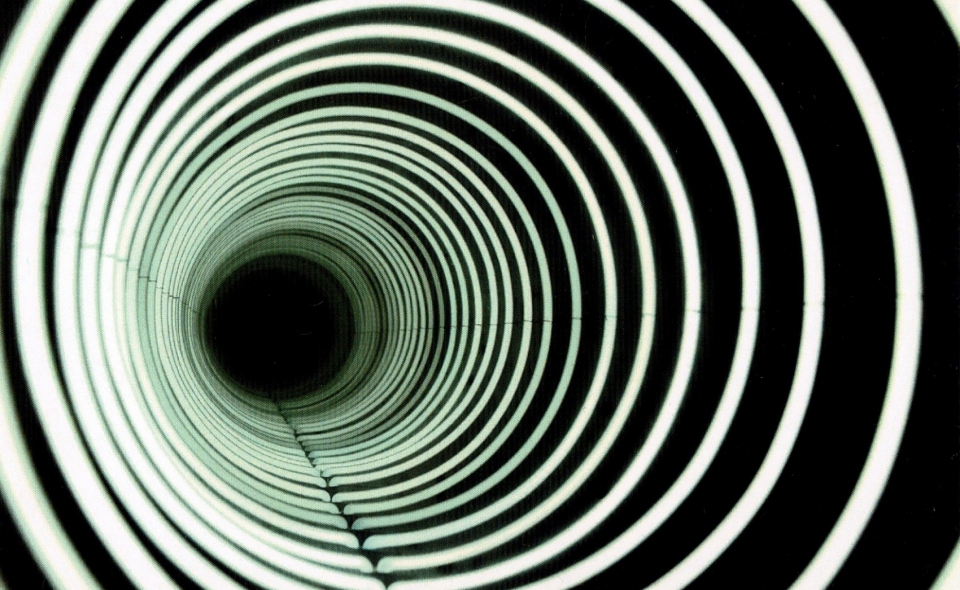“Non dobbiamo parlare del popolo ma parlare al popolo”, dichiarava Pierluigi Bersani in occasione di un dibattito col sindaco Sala alla Festa dell’Unità di Modena. Vi sono tuttavia almeno due domande da porsi per fare ciò e tali domande sono “chi è il popolo oggi?” e “cosa può fare una forza di sinistra per migliorarne la condizione?”. Per poter rispondere a queste due domande è necessario comprendere due cose. In primo luogo occorre guardare al versante dell’offerta politica e di come questa ha interagito col modello di capitalismo italiano nel produrre gli esiti che osserviamo oggi; da questa considerazione si possono trarre importanti conclusioni su come la politica possa contribuire a migliorare lo stato del sistema produttivo e del mercato del lavoro. Tuttavia occorre anche capire se vi sia lo spazio di manovra per poter implementare particolari soluzioni e riforme. In questo caso i vincoli all’azione politica più stringenti sono le scelte passate e la struttura della domanda politica, ovvero le preferenze degli elettori.
Questo articolo cerca di rispondere a tali domande, partendo da una prospettiva di sinistra. Poiché non vi è modo di tracciare una panoramica su tutto il percorso di riforme intrapreso negli ultimi anni, si guarderà soprattutto alle ultime riforme del mercato del lavoro che, insieme a quelle del welfare, costituiscono un periodo che Burroni e Trigilia hanno definito “riformismo incompleto” (1) . Partire da questa descrizione è fondamentale per capire in che modo si possano “colmare i vuoti” dell’offerta politica al fine di creare “vincoli interni” e “complementarietà istituzionali” con il sistema di produttivo.
Un riformismo incompleto per un capitalismo spaesato: una soluzione è possibile
Per quanto riguarda le riforme del mercato del lavoro, si riconosce un percorso con diverse tappe nel solco della continuità, in cui si è cercato di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. Le tappe principali di questo percorso sono la legge 196/1997, detta anche “legge Treu”, la “legge Biagi” del 2003, la “legge Fornero” del 2012 e il Jobs Act del 2015, che rappresenta ad oggi l’ultima fase di questo periodo. Fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 sono state introdotte forme di flessibilità come il lavoro interinale e gli incentivi a sostegno del part-time (legge Treu) nonché forme contrattuali nuove come il job sharing (Legge Biagi). Sono misure volte ad aumentare la flessibilità in “entrata”, che quindi coinvolge gli individui all’inizio della loro carriera lavorativa, per vedere misure riguardanti la flessibilità in “uscita” si dovrà aspettare la legge Fornero che, come noto, ha riformato l’articolo 18 dello Stato dei Lavoratori. È da qui che partirà il Jobs Act, che fra le sue misure principali vede l’introduzione delle tutele crescenti che prevedono che a un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo o giusta causa venga riconosciuto un indennizzo economico tarato sull’anzianità.
È indubbio che queste riforme abbiano aumentato l’occupazione (e diminuito la disoccupazione), almeno fino allo scoppio della crisi. Tuttavia, la qualità dell’occupazione creata non solo è stata bassa, ma è anche venuta a crearsi una sorta di “trappola della precarietà”. In Italia i lavori atipici non sono l’anticamera per ottenere lavori più stabili, anzi, più tempo si trascorre impiegati in lavori atipici e maggiore è la probabilità che il lavoro successivo sia a sua volta atipico. Il risultato più paradossale è che questa situazione sembra essere positivamente correlata con il livello di istruzione: più si è istruiti e più si è esposti al rischio di precarietà (2) . Questa situazione ha subito un peggioramento significativo con lo scoppio della crisi, come mostrano i dati del rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno del 2016, citati da Giuseppe Provenzano e Alessandro Aresu in un articolo recentemente pubblicato su Lo Stato Presente. Dopo il 2008, al contrario di quanto accaduto negli altri paesi, le “professioni cognitive altamente qualificate” hanno perso più di un milione di unità, i dati SVIMEZ parlano di un calo del 12,8%, contro una media europea del 4,6%. Va infine ricordato che queste riforme non sono riuscite a modificare una storica forma di dualismo del mercato del lavoro italiano, quella generazionale (3) : i lavoratori più giovani continuano ad essere maggiormente esposti ai rischi sociali vecchi e nuovi (4) .
È inevitabile chiedersi cosa sia mancato. Innanzitutto è mancata “l’altra faccia” della flessibilità, quella che guardando all’esperienza dei paesi nordici, specialmente quella danese, ha portato gli studiosi a coniare il termine “flexicurity”. È mancato quel mix di politiche del lavoro passive, per la protezione del reddito (5) , e attive, per favorire l’ottenimento di un lavoro, da cui non può prescindere un sentiero di riforme che diminuisce la sicurezza del posto di lavoro, facilitando assunzioni e licenziamenti. Sembrerebbe sia anche mancata l’enfasi sulla formazione e sull’apprendimento continuo tipico del modello nordico (6), elemento fondamentale se si intende creare occupazione di qualità. Ad esempio, in Danimarca viene fatto un uso molto frequente della job rotation. Un’azienda può rimpiazzare temporaneamente lavoratori in congedo, per malattia o per maternità e paternità, con dei disoccupati che hanno le competenze necessarie per svolgere quella mansione. In questo modo non vi sono perdite di produttività per l’azienda, che non paga il disoccupato (il quale continua a percepire il sussidio), permettendo all’individuo di apprendere nuove conoscenze e migliorare le possibilità di trovare un lavoro di qualità.
Bisogna inoltre tenere in considerazione lo stato del sistema produttivo italiano rispetto a paesi come Danimarca e Svezia. In questi ultimi infatti le imprese perseguono quella che Burroni chiama “la via alta dello sviluppo”, basata su innovazione e qualità di prodotti e servizi. Questo non è il caso dell’Italia, il cui sistema produttivo, nonostante la vocazione export-led delle medie imprese manifatturiere del Made in Italy, ha fatto fatica a produrre un modello di crescita riconoscibile, generando una stagnazione non indifferente (7) . Siamo quindi in presenza di un circolo vizioso, in cui misure di flessibilità che trascurano la qualità dell’occupazione si legano ad un sistema produttivo poco interessato ad innovazione e qualità, rinforzando di conseguenza il rischio di essere precari. Come si può rompere questo legame, in modo da “ricalibrare” il sistema produttivo risolvendo allo stesso tempo l’incompiutezza del sentiero di riforma?
Considerando gli elementi principali del capitalismo italiano, unitamente ad una struttura delle relazioni industriali non certo paragonabile a quella dei paesi nordici, probabilmente la proposta di Giuseppe Provenzano e Alessandro Aresu circa la costruzione di un “IRI della conoscenza” (http://www.lostatopresente.eu/2016/12/la-politica-industriale-e-tornata-ora-serve-un-nuovo-iri-della-conoscenza.htmlb) potrebbe essere una buona soluzione (8) . Ricostituire un nuovo IRI aiuterebbe a disegnare e implementare politiche industriali di lungo respiro, che permettano allo Stato di “scegliere chi vince e chi perde”. Si potrebbe pensare alla creazione di un soggetto pubblico sul modello della Darpa statunitense a cui affiancare l’impegno diretto dello Stato nella produzione nella produzione di beni e tecnologie di frontiera. Unitamente a ciò si potrebbe anche pensare, facendo riferimento all’ultimo lavoro di Atkinson, la creazione di un fondo sovrano finalizzato all’accrescimento del “patrimonio netto dello Stato con investimenti in aziende e proprietà immobiliari”(9). Tutto questo creando una rete con le aziende private per spostare il sistema dalla situazione attuale in cui gli investimenti in innovazione e qualità dei beni e servizi stentano a decollare.
Ma un nuovo IRI potrebbe essere un punto di partenza anche per la costruzione di quell’altra faccia della flessibilità che è venuta a mancare. Si potrebbero quindi disegnare programmi di formazione per i disoccupati, insieme ad un sistema diverso di sussidi di disoccupazione, che sfocino in un massiccio uso della job rotation all’interno delle aziende che comporrebbero il nuovo IRI. Questo porterebbe la creazione di un “IRI della conoscenza” ad un livello diverso: lo Stato riuscirebbe quindi ad incanalare al suo interno sempre nuove conoscenze e competenze tramite la job rotation. Di conseguenza si potrebbe ulteriormente favorire lo spostamento su un diverso sentiero di sviluppo e potrebbe favorire il coordinamento con le imprese private, garantendo ai disoccupati la possibilità di svolgere mansioni qualificate in aziende innovative ed essere inseriti in un percorso arricchente per il lavoratore.
È politicamente fattibile?
È chiaro che intorno a idee simili debba essere costruito un consenso solido, senza il quale un simile programma non potrebbe mai trovare applicazione concreta. Bisogna riflettere su quali strati della società sarebbero maggiormente favorevoli ad un progetto del genere; si tratta sostanzialmente di capire con quali “referenti sociali” bisognerebbe costruire una futura base elettorale.
Con la terziarizzazione dell’economia e, più in generale, con la transizione ad una “economia della conoscenza” sono cambiate molte cose e sarebbe un errore fermarsi alla distinzione fra classi ricche, medie e povere. Già l’Istat, nel suo rapporto del 2017, aveva “ricostruito” le classi sociali raggruppandole in nove gruppi (10). In questo articolo si intende fare qualcosa di simile e verranno adottate le categorie proposte da Beramendi, Häusermann, Kitschelt e Kriesi (d’ora in poi Beramendi et al.), i quali hanno svolto un lavoro dedicato proprio alla “politica del capitalismo avanzato” (11). Gli autori hanno mappato le preferenze degli elettori lungo due dimensioni, la prima riguarda l’intervento statale nell’economia mentre la seconda riguarda la preferenza per politiche di investimento o di consumo. Le prime influenzano le risorse che gli individui avranno nel futuro, ad esempio ottenendo vantaggi derivanti da un set di politiche pubbliche che aiutano le persone ad ottenere maggiori guadagni dal mercato. Le seconde invece influenzano le risorse degli individui immediatamente e l’esempio più calzante è quello dei trasferimenti monetari che possano derivare, per fare un esempio da sussidi di disoccupazione. Gli autori sostengono anche che vi sia un certo grado di sovrapposizione fra investimento e “universalismo” e consumo e “particolarismo”, tuttavia per semplicità in questo articolo si tratteranno le due dimensioni di natura politico-economica.
Beramendi et al. suddividono l’elettorato in quattro categorie: professionisti socioculturali, lavoratori a bassa qualifica e lavoratori manifatturieri, piccola borghesia, professionisti finanziari, tecnici esperti e manager. I primi due gruppi sono favorevoli ad un forte intervento statale nell’economia mentre gli ultimi due preferiscono uno Stato meno presente; tuttavia, i professionisti socioculturali e finanziari tendono a sostenere politiche di investimento mentre i lavoratori a bassa qualifica e la piccola borghesia preferiscono politiche di consumo.
L’unica coalizione che potrebbe essere disposta ad accettare un’offerta politica come quella delineata in precedenza sarebbe quella che vede i lavoratori a bassa qualifica unirsi agli operatori socioculturali (nei paesi nordici questa alleanza ha coinvolto anche tecnici, manager e professionisti del settore finanziario). Vi sarebbe unione di vedute sul ruolo dello Stato ma si dovrebbero fare compromessi sull’equilibrio fra politiche di investimento (12) e di consumo.
Nel caso italiano si devono però fare i conti con lo scarso peso dei professionisti socioculturali, quegli individui altamente qualificati che lavorano nell’istruzione, nella ricerca, nel terzo settore e nella cultura. Questa categoria, che in Scandinavia rappresenta il 20% della forza lavoro, nei paesi sud-europei raggiunge solo il 7%, cosa che renderebbe complicata l’implementazione di politiche di investimento, dal momento che i lavoratori a bassa qualifica preferirebbero un’offerta politica diversa. Tuttavia, Beramendi et al. specificano che fra i lavoratori sia necessario distinguere due sottocategorie: da un lato i “colletti blu”, dall’altro i lavoratori a bassa qualifica del terziario. Questi ultimi sono tendenzialmente impiegati in lavori atipici e sono più esposti al rischio di essere catturati nella trappola della precarietà. Ciò fa si che i lavoratori a bassa qualifica del terziario siano più favorevoli a politiche di investimento (13), quindi anche all’implementazione di politiche attive del lavoro incentrate sull’investimento in capitale umano come quelle descritte in precedenza.
I lavoratori a bassa qualifica del terziario potrebbero quindi essere un importante gruppo di riferimento con cui dialogare per costruire una solida base elettorale. Questo non significa abbandonare i colletti blu e i professionisti socioculturali, anzi una simile strategia deve necessariamente puntare a creare un ponte fra questi due segmenti di classe lavoratrice. Quello che si suggerisce è che il consenso dei lavoratori a bassa qualifica del terziario è cruciale per l’implementazione di politiche di investimento (14). Va inoltre detto che questa categoria necessita un’attenzione maggiore da parte della politica. Nel manifatturiero le relazioni industriali e la contrattazione collettiva, nonostante i cambiamenti che hanno decentrato il livello della contrattazione, introducendo deroghe e dando più risalto alla contrattazione aziendale (15) , sono ancora importanti per la redistribuzione. Inoltre gli operai sono un gruppo più politicamente mobilitato, anche per il ruolo ancora importante svolto da corpi intermedi come i sindacati. Nel terziario la situazione è invece molto diversa: da un lato le relazioni industriali faticano a produrre gli stessi esiti redistributivi del manifatturiero (16) , dall’altro i lavoratori dei servizi non sono politicamente mobilitati e questa è probabilmente la sfida più difficile soprattutto in un momento come questo.
Allo stesso tempo è fondamentale evitare una saldatura fra i lavoratori manifatturieri e dei servizi con la piccola borghesia, perché questa coalizione tende a sostenere governi di destra “liberal-protezionista”, con uno Stato forte nel proteggere la sua economia dal commercio internazionale ma che invece tende ad essere debole nella regolamentazione del mercato interno. Questa coalizione, oltre a preferire politiche di consumo, propenderebbe per soluzioni particolaristiche, da cui possono nascere anche sentimenti xenofobi (è anche per questo che è importante tenere a mente la parziale sovrapposizione fra investimento e universalismo e consumo e particolarismo).
Un’ultima considerazione va fatta sul tipo di democrazia che troviamo in Italia. Nonostante i tentativi di transitare ad un modello maggioritario, un altro errore che non ha certo aiutato, l’Italia sembra essere più vicina al modello consensuale. Questo significa che rincorrere l’elettorato centrista non sia una necessità pressante, pertanto una linea politica costruita intorno ad uno scheletro di idee come quelle appena presentate può essere perseguita in modo abbastanza radicale, per poi negoziarle con le altre forze politiche all’interno del parlamento.
Conclusioni
Una strategia che punti molto sul ruolo dello Stato nell’implementazione di politiche industriali (mirando soprattutto a creare quella rete di conoscenze discussa da Provenzano e Aresu che miri a riportare il sistema produttivo sulla “via alta dello sviluppo”) e di politiche attive del lavoro incentrate sull’investimento in capitale umano e conoscenze tramite un nuovo IRI è possibile. È tuttavia una strada impervia; da questo punto di vista non vi sono dubbi che sia un percorso in salita, ma è un percorso da cui una forza di sinistra può guadagnare molto.
Un simile piano coinvolge fortemente idee di quel social investment europeo che la crisi finanziaria e dei debiti sovrani hanno sostanzialmente messo in secondo piano. Eppure è probabilmente da piani del genere che può ripartire anche un’idea diversa di Europa, che miri finalmente ad un integrazione sociale e non solamente economica. Una sfida fondamentale sarà quindi anche la costruzione di un consenso intorno ai principi del social investment e dei principi espressi dal Trattato di Lisbona. Anche in questo caso la strada è in salita, ma è una strada che vale la pena intraprendere.
—
1 – Burroni, L. e Trigilia, C. (2012), Politics against Market: The Hard Way of Italian Capitalism, in Masanobu, I. (a cura di) Varieties of Capitalism, Types of Democracy, and Globalization, Abingdon, Routledge.
2 – Barbieri, P. e Scherer, S. (2009), Labour Market Flesibilization and Its Consequences in Italy, in “European Sociological Review”, vol. 25, n.6, pp 677-92.
3 – Barbieri, P. (2011), Italy: No country for young men (and women): The Italian way of coping with increasing demands for labour market flexibility and rising welfare problems, In Globalized labour markets and social inequality in Europe, pp. 108-145. Palgrave Macmillan, London.
4 – Il meccanismo di tutele crescenti del Jobs Act riproduce un simile dualismo, inoltre anche il funzionamento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) che, come si può leggere in un articolo di Roberto Rizza del 2015, è proporzionale ai guadagni precedenti e viene erogata per un periodo calcolato sulle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
5 – Ad esempio la “generosità” dei sussidi e l’ampiezza della platea dei potenziali beneficiari degli stessi.
6 – Burroni, L. (2016), Capitalismi a Confronto, il Mulino.
7 – Baccaro, L. e Pontusson, H.J. (2016), Rethinking Comparative Political Economy: The Growth Model Perspective, in “Politics and Society”, vol.44, n. 2, pp 175-207.
8 – Un’ulteriore soluzione per far sì che le aziende percorrano la “via alta dello sviluppo” sarebbe anche quella di introdurre il salario minimo, ciò aiuterebbe le aziende a fare uno sforzo maggiore nell’investire sui lavoratori e sulle loro competenze.
9 – Atkinson, A. (2016), Disuguaglianza: cosa si può fare? Raffaello Cortina Editore.
10 – Il rapporto Istat è stato recensito sul sito della rivista Pandora e può essere consultato al seguente link https://www.pandorarivista.it/articoli/litalia-nel-rapporto-annuale-istat-2017/
11 – Beramendi, P. Häusermann, S. Kitschelt, H. e Kriesi, H. (2015), Introduction: The Politics of Advanced Capitalism, in Beramendi, P. Häusermann, S. Kitschelt, H. e Kriesi, H. (a cura di), The Politics of Advanced Capitalism, pp 1-67, Cambridge University Press.
12 – Fra cui rientrano le politiche attive del lavoro orientate all’investimento su capitale umano e conoscenze.
13 – La maggiore sensibilità alle politiche di investimento all’interno di questo gruppo è dovuta anche alla maggior presenza di donne, che sono più interessate a soluzioni del genere anche per la necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
14 – Va specificato che questa strategia guarda soprattutto al contesto nazionale, ma è anche importante tenere a mente ciò che è avvenuto a livello locale. Non bisogna infatti dimenticare che nelle “regioni rosse” anche pezzi della piccola borghesia furono inclusi nelle coalizioni che sostennero il PCI, a dimostrazione che la presenza di una subcultura politica a livello locale può cambiare le cose. Al riguardo si può leggere la recensione del libro di Caciagli proprio su questi temi https://www.pandorarivista.it/articoli/addio-alla-provincia-rossa-cultura-politica-caciagli/
15 – Burroni, L. (2016), Capitalismi a Confronto, Il Mulino.
16 – Iversen, T., e Soskice, D. (2015), Democratic limits to redistribution: inclusionary versus exclusionary coalitions in the knowledge economy, in “World Politics”, 67(2), pp 185-225.